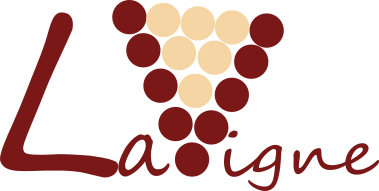C’è un prodotto che non si vede, ma si sente. Che non colora, non profuma, non allunga le ciglia né accende le labbra. Eppure, per molti è il punto di partenza, la base su cui costruire tutto il resto: il fondotinta.
Lo si ama o lo si teme. Alcune non escono senza, altre non ne sopportano la presenza. C’è chi lo preferisce invisibile e impalpabile, chi lo vuole coprente come una seconda pelle, chi giura su formule glow, chi solo sul matte assoluto. Ma alla fine, quasi tutte abbiamo avuto un “periodo fondotinta” nella vita, quel momento in cui sentivamo che un filo di prodotto poteva farci sentire… a posto. In armonia.
Per me è stato un gesto di esplorazione. Di trasformazione. Ma anche di difesa: un filtro sottile tra il mio volto e il mondo. Non trucco, ma traccia. Perché il fondotinta non disegna né scolpisce: uniforma, attenua, accompagna.
E non è certo una novità dei nostri tempi. Da secoli, donne (e uomini) in ogni angolo del mondo hanno cercato di controllare l’incarnato: con polveri, paste, unguenti, impasti e riti più o meno sicuri. L’ideale di pelle perfetta — o presunta tale — ha attraversato civiltà, mode, status sociali e rivoluzioni estetiche.
Come è accaduto per il rossetto, per il blush o per il mascara, anche il fondotinta racconta molto più di una semplice routine: racconta chi abbiamo voluto essere — e chi, forse, eravamo davvero.
Dall’Egitto a Versailles: l’incarnato come status sociale
Molto prima che si parlasse di “base trucco”, l’incarnato era già una dichiarazione. Nell’antico Egitto, uomini e donne usavano polveri a base di ocra gialla o rossa mescolate con grassi naturali per uniformare e scaldare il tono della pelle. Non solo per vanità, ma per imitare l’oro, simbolo del divino e della regalità. Una pelle uniforme e luminosa era segno di ordine, salute, armonia cosmica.
A Roma, l’ideale muta: si cerca una pelle chiara, levigata, quasi eterea. Le matrone romane schiarivano il volto con pasta di piombo, gesso, biacca, spesso tossici. Il pallore era sinonimo di purezza, tempo libero, status. Chi era costretto a lavorare al sole — contadine, serve — aveva un incarnato scuro, e quindi socialmente inferiore. Sbiancarsi il viso era, letteralmente, un modo per salire di rango.
Questo ideale prosegue per secoli e tocca il suo apice nelle corti rinascimentali e barocche, fino alla Versailles di Luigi XIV. Lì, più che in ogni altro luogo, il volto era una tela: ciprie pesanti, pomate color latte, parrucche e nei finti contribuivano a costruire un’immagine artificiale ma perfettamente codificata. Il cerone bianco, spesso ottenuto con composti velenosi, era considerato il massimo dell’eleganza.
Ma dietro quel biancore lattiginoso c’era un messaggio: non sono costretta a espormi, ho tempo per curarmi, appartengo a una classe che può permettersi la distanza dal reale. Il fondotinta, ben prima di essere tale, era già un linguaggio silenzioso ma chiarissimo.
XIX secolo: borghesia, decoro e il sogno della pelle naturale
Dopo l’eccesso barocco, l’Ottocento porta una nuova estetica. Il cerone cede il passo alla pelle “naturale”, o meglio, che appare tale, perché il trucco — ovviamente — non sparisce. Semplicemente, si nasconde. È il tempo della moderazione, del decoro, del “trucco che c’è ma non si vede”.
La nuova donna borghese deve apparire fresca, sobria, educata nella bellezza. La pelle deve essere levigata, uniforme, luminosa, ma in modo credibile. Troppo colore, troppa evidenza, troppa materia… e si rischia di scivolare nel cattivo gusto. Anche il make-up, come l’abito, diventa una questione morale.
Nascono allora pomate schiarenti, lozioni a base di ossido di zinco, ciprie finissime. Il fondotinta in senso moderno non esiste ancora, ma il desiderio di creare una base omogenea è ben presente. Le donne si affidano a prodotti semi-artigianali, spesso preparati in farmacia, oppure a “ricette casalinghe” tramandate di madre in figlia.
A teatro, però, la situazione è diversa. Le attrici e le cantanti usano ancora il cerone — spalmato a mano, pesante e occlusivo — per farsi vedere a distanza, e quella pratica, apparentemente lontana dalla vita quotidiana, influenzerà profondamente le prime formulazioni industriali del fondotinta nel secolo successivo.
Il viso, insomma, si fa ambizione discreta. Uniformarlo diventa sinonimo di cura, di rispetto per sé e per gli altri. Ed è in questa tensione tra naturalezza apparente e artifizio controllato che nascerà, di lì a poco, il fondotinta moderno.
XX secolo: nasce il fondotinta come lo conosciamo
Il Novecento è il secolo in cui il fondotinta prende forma. Letteralmente. Diventa una formulazione cosmetica autonoma, distinta dalla cipria, prodotta industrialmente e pensata per adattarsi a diversi tipi di pelle e incarnato.
All’inizio del secolo, Max Factor, truccatore delle star del cinema muto, inventa il primo “greasepaint” in versione più leggera, adatta al viso e alle riprese in primo piano. È pensato per attori e attrici, ma l’intuizione è destinata a cambiare la storia: se davanti alla cinepresa serve una base perfetta, perché non dovrebbe esserlo anche nella vita reale?
Così nascono i primi fondotinta in crema, in pasta, poi liquidi. E con l’avvento della pubblicità e dei grandi magazzini, anche le donne comuni iniziano a desiderare quel viso da schermo, uniforme, radioso, senza imperfezioni.
Negli anni ’30 e ’40, le confezioni diventano oggetti desiderabili: tubetti eleganti, scatoline dorate, specchietti integrati. E i toni? Sempre chiarissimi: l’ideale di pelle è ancora quello anglosassone, con poco spazio per la diversità cromatica. Ma il fondotinta ha ormai conquistato il suo posto: non è più solo trucco, è base identitaria.
Negli anni ’50, con l’esplosione del beauty post-bellico, il fondotinta diventa protagonista del volto perfetto: incarnato matte, impeccabile, senza sbavature. Lo si abbina al rossetto, al blush, al mascara.
Il fondotinta è dappertutto: nei beauty case, nelle riviste, nella cultura pop. E se da un lato omologa, dall’altro dà voce a una nuova possibilità: quella di scegliere come presentarsi. Anche solo per gioco.
Anni ’70 – 2000: tra liberazione, marketing e nuovi ideali
Negli anni ’70, il fondotinta comincia a perdere il suo alone di “obbligo” e diventa sempre più scelta consapevole. Le istanze femministe, il ritorno alla natura, il rifiuto dei codici estetici imposti portano molte donne a rivendicare il diritto di non indossarlo affatto. Si afferma così una nuova estetica: quella della pelle reale, della texture visibile, dell’imperfezione come segno di libertà.
Ma mentre una parte del mondo beauty si alleggerisce, l’industria non si ferma. I marchi iniziano a sviluppare formule più leggere, versatili, adattabili, capaci di seguire — piuttosto che coprire — l’incarnato. Si sperimenta con texture fluide, compatte, in mousse, e arrivano i primi fondotinta oil-free, pensati per adolescenti e pelli miste.
Negli anni ’80, l’estetica cambia di nuovo: torna l’effetto perfezione, ma in chiave performativa. Il fondotinta si abbina a contouring, ciprie opache, blush accesi. È il volto da copertina, da passerella, da videoclip. Si parla di “base impeccabile”, “zero pori”, “copertura totale”. È il tempo dell’over-makeup, e il fondotinta è la tela su cui tutto si costruisce.
Negli anni ’90 e 2000, infine, assistiamo a una nuova inversione di tendenza: torna l’ossessione per la pelle perfetta, ma in modo apparentemente naturale. I fondotinta si fanno più leggeri, quasi invisibili, promettono finish vellutati, effetto seconda pelle, glow da ragazza di ritorno dallo yoga. E intanto, si moltiplicano le nuance: finalmente, lentamente, si comincia a parlare di incarnati diversi, e i brand iniziano ad allargare la gamma dei toni disponibili.
Il fondotinta non è più solo un prodotto. È un codice estetico da decifrare, una scelta personale da modulare, un segnale sottile su chi vogliamo essere — o sembrare.
Il fondotinta oggi: inclusività, skincare e glow consapevole
Nel 2025, parlare di fondotinta significa parlare di identità, inclusività, libertà di scelta. Le formule sono sempre più ibride: skincare e make-up si fondono in prodotti che non si limitano a “coprire”, ma promettono di prendersi cura della pelle. Acido ialuronico, niacinamide, SPF: il fondotinta è anche trattamento, e questo lo rende sempre più desiderabile anche tra chi, un tempo, lo evitava.
La vera rivoluzione, però, è arrivata con un nome: Fenty Beauty. Nel 2017, il brand fondato da Rihanna ha cambiato le regole del gioco lanciando 40 (poi 50) tonalità in una sola collezione. Da lì in poi, nessun marchio ha più potuto ignorare la diversità cromatica della pelle umana. Il messaggio è chiaro: non è l’utente a doversi adattare al prodotto, ma il contrario.
E così, oggi il fondotinta si presenta in mille forme: liquido, in stick, in cushion, compatto, in gocce miscelabili. Opaco o glow, a copertura totale o effetto nude. Alcuni si applicano con le mani, altri con spugnette high-tech. Ognuno ha il suo. O sceglie di non averne affatto.
Anche maison storiche come Chanel — da sempre maestra nell’equilibrio tra eleganza e innovazione — hanno accolto questa trasformazione. Dalla linea Les Beiges, con texture ultra-leggere e luminose che assecondano la pelle senza appesantirla, fino al fondotinta N°1 de Chanel, trattante e sostenibile, l’incarnato perfetto non è più solo questione estetica, ma anche di benessere e consapevolezza.
Perché il fondotinta oggi è una scelta, non un dovere. Un piccolo gesto per stare meglio nella propria pelle, o semplicemente per giocare con essa.