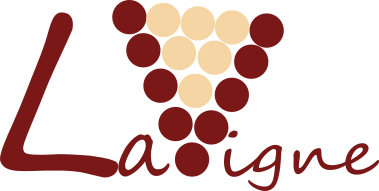Ci sono brand che vestono. E poi c’è Prada, che pensa. Che osserva. Che non ha mai cercato l’approvazione, ma l’ha ottenuta comunque — con un sopracciglio sollevato, un taglio asimmetrico, un tessuto tecnico elevato a forma d’arte.
Parlare di Prada significa entrare in un territorio affascinante e un po’ spigoloso, dove l’estetica non è mai scontata e ogni collezione è una dichiarazione culturale più che un esercizio di stile. È il brand che ha fatto del nylon un feticcio, che ha trasformato il brutto in bello, che ha preso le passerelle e le ha rese uno spazio di pensiero. E che — sì — ha influenzato una generazione intera di donne (e uomini) che volevano vestirsi bene, ma anche sentirsi intelligenti mentre lo facevano.
Io con Prada ho sempre avuto un rapporto di timore reverenziale misto a desiderio: non è una moda che si indossa distrattamente. È una scelta, un’affermazione. E forse anche una sfida.
In questo articolo ti porto dietro le quinte della maison milanese: dalla pelletteria degli inizi ai codici sovversivi di Miuccia, dalla filosofia dell’intelligenza vestita bene al ruolo culturale che Prada ha assunto nel tempo. Perché sì, ci sono vestiti che piacciono. E poi ci sono quelli che ti cambiano il modo di vedere le cose.
E Prada, da oltre quarant’anni, fa esattamente questo.
Le origini: dalla Galleria Vittorio Emanuele a Miuccia
La storia di Prada comincia dove cominciano molte storie milanesi: nella Galleria Vittorio Emanuele II, tra vetrine lucide, marmi storici e quell’eleganza sobria che profuma di riservatezza lombarda. È il 1913 quando Mario Prada e il fratello Martino aprono “Fratelli Prada”, una boutique specializzata in pelletteria di altissima qualità: bauli da viaggio, valigie, articoli da accessorio per una clientela colta, benestante e discretamente esigente.
Il lusso, in quel momento, è fatto di pelle lavorata con sapienza, cuciture invisibili e discrezione assoluta. Prada cresce, diventa fornitore ufficiale della Casa Reale Italiana, e si afferma come simbolo di artigianato d’élite. Ma il vero cambio di passo arriva nel 1978, quando entra in scena Miuccia Prada. Nipote del fondatore, laureata in scienze politiche, appassionata di teatro, femminista dichiarata ed ex allieva del Piccolo Teatro. Tutto, tranne che prevedibile.
Quando prende in mano l’azienda di famiglia, Miuccia non si limita a proseguirne la tradizione. La smonta, la ripensa, la ribalta. A partire da un materiale che, all’epoca, nessuno avrebbe mai osato definire “di lusso”: il nylon. Sì, proprio lui. Anonimo, tecnico, industriale. Trasformato in zaino minimalista e venduto a prezzi da alta moda. Un gesto che molti, inizialmente, faticano a comprendere. Ma che, col tempo, cambia le regole del gioco.
Quel gesto — quella sfida silenziosa — è già tutto Prada. Intelligente, anticonvenzionale, rigoroso e insieme irriverente. Il primo seme di una rivoluzione stilistica che da lì in poi non si sarebbe più fermata.
Filosofia: pensare la moda, oltre la moda
Se c’è una cosa che Prada ha sempre fatto, è pensare prima di piacere. O meglio: piacere proprio perché pensa. La filosofia della maison non ha mai cercato la bellezza classica, la seduzione immediata o la conferma rassicurante dei trend. Ha scelto, invece, di costruire un linguaggio tutto suo — complesso, stratificato, profondamente intellettuale — e di portarlo in passerella come fosse un saggio vestito bene.
«L’eleganza è intelligenza», direbbe Miuccia. E, in effetti, l’identità di Prada è questa: una moda che si interroga, che problematizza, che mette in discussione. A volte anche il concetto stesso di “bello”. Il gusto tradizionale viene sovvertito, riletto, decostruito. L’abbigliamento non è mai decorativo, ma espressivo. È linguaggio, e a volte anche dissenso.
E a proposito di linguaggio: la moda altro non è che un sistema di codici. Gli abiti, gli accessori, i colori sono l’alfabeto di una lingua che non ha confini, che si declina in accenti nazionali — stile italiano, street style americano, glamour francese — ma che sa farsi comprendere senza usare parole. Attraverso ciò che indossiamo possiamo raccontare come ci sentiamo, cosa rappresentiamo, chi vogliamo essere — o cosa rifiutiamo di diventare. Ed è per questo che la moda è tutt’altro che frivola.
E Prada lo sa bene.
La donna Prada non è mai passiva. Non è vestita per compiacere. È autonoma, sfuggente, a tratti ironica, perfettamente consapevole di chi è — o, perlomeno, di chi non vuole essere. Una figura che cambia con gli anni, ma che mantiene sempre un’aura di lucidità, indipendenza e leggerezza concettuale. E lo stesso vale per la moda uomo, spesso pensata come territorio di ambiguità, tensione e tensione estetica.
Tutto questo si riflette nelle scelte creative: tagli che disorientano, abbinamenti cromatici inaspettati, silhouette sbilanciate, materiali dissonanti. Nulla in Prada è mai semplicemente “carino”. E spesso, a un primo sguardo, non lo è affatto. Ma è proprio lì, in quella zona di dubbio, che si annida il suo potere.
In un sistema che ha spesso bisogno di conferme, Prada ha scelto l’eleganza dell’ambiguità. E proprio per questo, continua a sorprendere.
Impatto culturale: Prada come riflessione sociale
Parlare dell’impatto culturale di Prada significa riconoscere come un’estetica non convenzionale possa ridefinire il gusto collettivo. Ciò che ieri sembrava difficile, ostico, “strano”, oggi è iconico, desiderabile, copiato ovunque. E questa trasformazione è spesso iniziata proprio da Prada.
Il suo contributo va ben oltre l’abito: è un modo di essere e di guardare il mondo, un pensiero vestito bene — come una lente critica sulla società. Le sfilate non raccontano solo tendenze, ma mettono in scena identità, riflessioni, tensioni, cambiamenti. Ogni collezione è un piccolo saggio sociologico in tessuto.
E se oggi siamo così abituati a decodificare i look di una passerella come se fossero paragrafi di un discorso — se interpretiamo un outfit come una posizione, una provocazione, un messaggio — è anche grazie a Prada. Il brand ha insegnato che la moda può parlare il linguaggio della cultura, senza perdere eleganza, né desiderabilità.
Un esempio emblematico? La canottiera bianca presentata nella collezione Autunno/Inverno 2022-23. Un capo basico, quasi invisibile, che Prada ha trasformato in oggetto del desiderio. Indossata da Kaia Gerber e Hunter Schafer, la canottiera, impreziosita dal logo triangolare, è diventata un must-have, simbolo di come Prada sappia ribaltare e nobilitare i codici della moda.
Il cinema ha colto questo potere prima di molti altri. Il diavolo veste Prada, uscito nel 2006, è diventato un manifesto pop, un inno ironico e affilato al potere silenzioso (ma non troppo) dell’industria del lusso. E anche se Meryl Streep indossa abiti firmati Valentino e Donna Karan, il nome Prada nel titolo dice già tutto: è l’emblema di una moda che dirige, influenza, anticipa. Una moda che pensa, e quindi guida.
Miuccia stessa, nel frattempo, è diventata una figura di riferimento intellettuale e femminile, più che una semplice designer. È invitata a conferenze internazionali, citata nei saggi di moda e sociologia, considerata tra le menti più influenti del fashion system. Prada, insomma, non veste il tempo: lo attraversa, lo analizza e spesso lo anticipa.
Collaborazioni e innovazioni: tra arte, architettura e sostenibilità
Prada non collabora tanto per stupire. Collabora per costruire un pensiero condiviso, per dare voce a linguaggi complementari. Quando nel 2020 viene annunciata la co-direzione creativa tra Miuccia Prada e Raf Simons, molti restano sorpresi: due personalità così forti, due visioni così nette. Ma è proprio in quell’incontro che Prada si conferma laboratorio vivo di dialogo e trasformazione. Il risultato? Collezioni che ibridano minimalismo e concettualismo, tailoring e tensione culturale, in un equilibrio sempre raffinato e mai banale.
Ma le collaborazioni non si fermano alla moda. Il mondo di Prada si allarga da anni all’arte, all’architettura, al design. Lo dimostra la creazione della Fondazione Prada, spazio espositivo permanente inaugurato a Milano nel 2015 su progetto di Rem Koolhaas, vera e propria estensione culturale della maison. Un luogo dove non si vendono abiti, ma si coltiva pensiero. Dove la bellezza non è solo da indossare, ma da interrogare.
C’è poi Miu Miu, l’etichetta “minore” (si fa per dire), fondata nel 1993 e pensata come territorio di sperimentazione estetica più libero, più giovane, più eccentrico. Anche qui, nulla è lasciato al caso: ogni collezione è una storia da raccontare, una provocazione sussurrata, un gioco serio.
E infine, c’è la sostenibilità, un tema che Prada ha affrontato in modo concreto e progressivo, lontano dal greenwashing. Il progetto Re-Nylon, lanciato nel 2019, ha segnato il ritorno al materiale-feticcio della maison — il nylon, appunto — ma in versione rigenerata ed eco-responsabile, ottenuta dal riciclo di rifiuti plastici e reti da pesca. Un’operazione che è insieme memoria, innovazione e responsabilità.
In tutto questo, il fil rouge resta la coerenza. Prada non rincorre le tendenze: le crea, le interroga, e poi le supera.
Lo stile come pensiero
Prada non è mai stata una moda da primo colpo d’occhio. È una moda che ti costringe a tornare indietro, a guardare meglio, a chiederti: perché proprio così? Eppure, è proprio questa capacità di non piacere subito, di non compiacere, a renderla così affascinante.
È il brand che ci ha insegnato che non esiste bellezza senza pensiero, che anche un taglio spigoloso, una gonna storta, una canottiera bianca possono raccontare una rivoluzione. È la prova che la moda — quella vera — non è mai soltanto decorazione. È scelta, è messaggio, è identità.
E se da più di quarant’anni Prada continua a definire il gusto di chi ama vestirsi con testa, cuore e ironia, è perché ha sempre trattato la moda per ciò che è davvero: un linguaggio raffinato, universale, imprevedibile. Un modo per esserci. Ma anche — e soprattutto — per dire qualcosa di sé.
Leggi anche
- Femminile, libero, leggero: il boho chic è la tendenza da amare quest’estate
- Da musa a regina: come Donatella Versace ha trasformato un’eredità in leggenda
- Le 5 tendenze del 2025 che devi conoscere
- Animalier: maneggiare con cautela
- Il ritorno del mocassino, con il calzino bianco
- Giorgio Armani: maschile, plurale.
- Storia di Louis Vuitton: origini, monogramma e rinascite di una leggenda del lusso