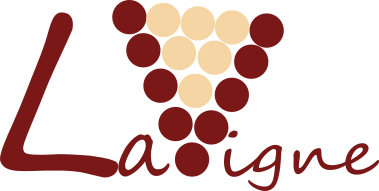C’è un gesto che compio quasi senza pensare. Davanti allo specchio, in quei cinque minuti rubati alla fretta del mattino, afferro il mascara. Uno, due passate — massimo tre se mi sento audace. Ed ecco: lo sguardo cambia, si apre, si definisce. Non è trucco teatrale, è più sottile. È come mettere un punto fermo alla frase del viso.
Il mascara è questo: una parentesi intensa tra lo sguardo e il mondo. Un dettaglio minuscolo che può però dire tutto. Forse per questo è diventato un prodotto così universale: lo usano le minimaliste che vogliono sentirsi “giuste” anche senza altro, le maximaliste che lo stratificano con passione, le romantiche, le pragmatiche, le indecise.
Eppure, dietro ogni piccolo scovolino c’è una storia lunga, affascinante, profonda. Dalle palpebre tracciate delle regine egizie ai tubetti satinati delle maison contemporanee, il mascara racconta i nostri sguardi — e tutto ciò che hanno voluto dire nei secoli.
Non solo bellezza: protezione, potere, seduzione, ribellione. Il mascara ha sempre guardato il mondo dritto negli occhi.
Origini antiche: khôl, carbone e protezione
Molto prima che si parlasse di ciglia “volumizzate” o “allungate”, lo sguardo era già protagonista. Nell’antico Egitto, uomini e donne tracciavano una linea scura attorno agli occhi con il khôl, una polvere a base di galena, carbone e minerali. Il risultato? Occhi profondi, allungati, misteriosi. Ma non era solo estetica: si credeva che il trucco proteggesse dallo sguardo maligno, tenesse lontane le malattie, invocasse il favore degli dèi.
Era bellezza, certo, ma anche potere. Cleopatra, Nefertiti, i faraoni: tutti indossavano lo sguardo come una maschera sacra. Le ciglia, nere e marcate, contribuivano a questo effetto magnetico. In fondo, non c’è nulla di più diretto — e pericoloso — di uno sguardo che ti fissa dritto nell’anima.
Anche in Grecia e a Roma, l’accento sugli occhi restava forte. Si usavano unguenti e cenere per colorare le ciglia e rinforzarle, e l’idea di sottolineare lo sguardo era già legata a status, sensualità e mistero. Chi poteva permetterselo lo faceva, perché il volto era già linguaggio.
E così, mentre il fard colorava le guance come segno di vitalità e il rossetto scriveva messaggi di forza e femminilità, lo sguardo si faceva scudo e specchio. Quella linea scura, quell’ombra, quel tratto sulle ciglia dicevano più di mille parole. Come succede ancora oggi.
XIX secolo – L’antenato del mascara moderno
Fino al XIX secolo, truccare le ciglia restava un rituale fatto in casa: unguenti, cenere, carbone vegetale, burro, lanolina… Nessun packaging satinato, nessuno scovolino, ma già il desiderio di intensificare lo sguardo era ben chiaro.
Poi arrivò lui: Eugène Rimmel. Il nome ti dice qualcosa? Esatto: è proprio da lui che deriva il termine “rimmel” ancora oggi usato in molte lingue per indicare il mascara. Visionario profumiere inglese di origini francesi, negli anni ’60 dell’Ottocento inventò un prodotto a base di vaselina e pigmenti neri che, applicato con una piccola spazzola, scuriva e allungava visibilmente le ciglia.
Era nato il primo mascara “moderno”, anche se il termine ufficiale sarebbe arrivato solo più tardi. La cosa curiosa? Era pensato sia per le donne che per gli uomini. Ancora una volta, lo sguardo non conosceva genere.
Poco dopo, anche Helena Rubinstein, un altro dei grandi nomi della cosmesi mondiale, avrebbe contribuito a perfezionare il prodotto: texture più morbide, migliori strumenti di applicazione, più sicurezza per l’occhio. Il mascara da cake — una sorta di pastiglia da inumidire e applicare con pennellino — avrebbe resistito fino agli anni ’50, quando finalmente arrivò il tubo con scovolino come lo conosciamo oggi.
Il fascino di quelle prime confezioni? Innegabile. Astucci in bachelite, scritte dorate, specchietti tascabili: oggetti del desiderio ancor prima che strumenti di trucco.
Intanto, la moda dello sguardo intenso cresceva. Perché, come per le guance ravvivate dal blush, anche le ciglia raccontavano un umore, uno stile, un’epoca. E stavano per entrare ufficialmente nel mito.
Anni ’20 – ’50: il mascara diventa glamour
Con l’arrivo del cinema muto, le espressioni diventano protagoniste. Senza la voce, è lo sguardo a raccontare tutto. E le ciglia, allungate e scurite con cura, iniziano a fare la differenza. È così che il mascara diventa strumento scenico prima, poi oggetto del desiderio.
Negli anni ’20, mentre le flapper rivoluzionano il modo di vestirsi, ballare e truccarsi, le ciglia si fanno teatrali: si scuriscono, si allungano, si arricciano con pinzette bollenti (sì, davvero). Non esistono ancora i mascara “istantanei”, ma la routine trucco comprende già il piccolo gesto quotidiano sulle ciglia. Il beauty case comincia a popolarsi di cake da inumidire, pennellini da portare ovunque e… tanta pazienza.
Negli anni ’30, Hollywood consacra il mascara: le star del grande schermo — da Greta Garbo a Marlene Dietrich, da Bette Davis a Rita Hayworth — definiscono un nuovo standard di bellezza. Occhi magnetici, ciglia finissime ma lunghissime, ombre perfettamente sfumate. Lo sguardo deve affascinare, intrigare, incantare. Ed ecco che il mascara smette di essere un piccolo vezzo e diventa parte della grammatica del volto.
È in questo periodo che si sviluppano i primi veri scovolini: piccoli applicatori pensati per pettinare e distribuire il prodotto in modo uniforme, anticipando di decenni il boom di formule e forme personalizzate.
Negli anni ’40 e ’50 il mascara si consolida come must beauty. L’estetica post-bellica vuole volti ordinati, occhi definiti, femminilità composta ma affilata. Il mascara — spesso nero o marrone — si applica con precisione, dando struttura e apertura allo sguardo. E la donna che lo indossa è sia madre, che lavoratrice, che soggetto glamour. Il gesto quotidiano dello scovolino è una firma sul viso, un atto di presenza delicata ma decisa.
Nel frattempo, le grandi maison iniziano a mettere il mascara in primo piano nelle pubblicità: Chanel, Revlon, Estée Lauder, tutte raccontano la forza di uno sguardo che “non ha bisogno di dire molto”. Perché sì, le parole si possono scegliere. Ma le ciglia… parlano da sole.
Anni ’60 – ’80: tra Twiggy, disco e volumi
Gli anni ’60 hanno rivoluzionato lo sguardo. E no, non è un modo di dire. Con il boom della moda giovanile e la comparsa di nuove icone — prima fra tutte Twiggy, con le sue ciglia disegnate anche sulla palpebra inferiore — il mascara da “rifinitura” si trasforma in strumento espressivo a tutti gli effetti.
Le ciglia si fanno grafiche, “a raggiera”, enfatizzate da passate multiple, piegaciglia, pennelli sottilissimi. È l’epoca dell’occhio da bambola, del trucco mod, delle confezioni colorate e del mascara che si mette anche sulle ciglia inferiori. Il viso diventa una tela, lo sguardo una dichiarazione di stile. Il mascara non basta più: arrivano le ciglia finte, le extension artigianali, le versioni colorate, per chi osa turchese, lilla, verde prato.
Negli anni ’70 l’estetica si scalda, si fa più bohémien. Il mascara accompagna look hippie e naturali, ma continua a essere presente. Non più per teatralizzare, ma per definire con disinvoltura. Le ciglia restano piene, anche se meno scolpite. Il focus torna sugli occhi, e il mascara resta un gesto di continuità.
Poi arrivano gli anni ’80. Ed è di nuovo spettacolo. Il trucco diventa esagerato, luminoso, metallico. Le ciglia? Devono vedersi. Longe, curve, magari glitterate. Il mascara si fa triplo, extra black, volumizzante, e le pubblicità promettono risultati da passerella. “Ciglia a ventaglio”, “effetto drammatico”, “sguardo teatrale”: il linguaggio si fa esplicito, performativo. Non si cerca più la naturalezza, ma la potenza. L’impatto.
In questi decenni, il mascara non è più solo un prodotto beauty. È un linguaggio visivo, un’estetica generazionale, un modo per stare al centro della scena anche solo con gli occhi.
Dagli anni ’90 ad oggi: definizione, precisione e… effetto wow
Negli anni ’90, l’estetica cambia direzione. Dopo l’eccesso degli ’80, il beauty vira verso il minimalismo, l’essenzialità, il “less is more”. E il mascara? Resta, ma si fa silenzioso. Le ciglia sono definite, ma naturali; curate, ma invisibili. Le formule migliorano: arrivano mascara waterproof, allunganti, incurvanti, sempre più precisi, sempre più resistenti. Lo scovolino diventa protagonista: da dritto a curvo, da fine a bombato, da fibra a silicone.
Il mascara, insomma, si specializza. Ogni sguardo ha il suo alleato, e il prodotto diventa tecnico, quasi chirurgico. Si parla di “precisione”, “effetto seconda pelle”, “zero grumi”. Le pubblicità cambiano tono: meno teatrali, più scientifiche. L’effetto deve esserci, ma non vedersi. O almeno così, fino a un certo punto.
Perché con l’arrivo dei 2000, e poi dei 2010, il mascara si reinventa ancora. L’effetto wow torna di moda: ciglia lunghissime, visibilmente finte (ma solo un po’), look editoriali ispirati alle passerelle. Il mascara si stratifica, si abbina a primer, a fibre, a formule “lash extension-like”. Si parla di “ciglia da bambola”, di “sguardo aperto”, di “volume panoramico”.
Nel frattempo, arrivano i mascara clear, trasparenti, usati anche sulle sopracciglia. I mascara marroni per look più soft. Quelli blu, viola o glitter, ripescati da un passato che non è mai davvero passato.
E poi c’è TikTok. Dove lo scovolino è di nuovo protagonista. Dove le beauty creator mostrano trucchi, stratificazioni, metodi per incurvare le ciglia con cucchiai, phon, eyeliner liquido. Dove il mascara diventa ancora una volta rituale, community, racconto collettivo.
Oggi il mascara è pratico, poetico, personale. Può essere l’unico prodotto che usi. Oppure uno dei dieci. Ma è lì, nel beauty case, fedele, versatile, insostituibile.
Perché in fondo, anche solo una passata cambia tutto.