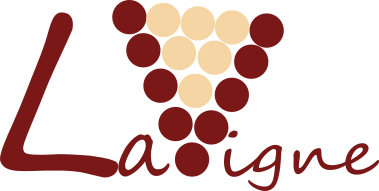Certe notizie fanno scattare un riflesso pavloviano: l’annuncio di Il Diavolo veste Prada 2 ha attivato la memoria visiva di milioni di spettatrici, risvegliando maglioncini cerulei, sopracciglia alzate, stivali scollati e una collezione infinita di outfit da sogno. Ma passata l’euforia da “ritorno del mito”, resta una domanda scomoda, forse la più onesta: ne abbiamo davvero bisogno? Oppure ci stiamo semplicemente aggrappando all’illusione, elegantissima, certo, che basti un tailleur couture per farci dimenticare che il mondo, e noi con lui, siamo cambiati?
Il sequel arriva in un momento strano: l’industria creativa è esausta, il mito della carriera a ogni costo vacilla, la Gen Z parla apertamente di burnout e soft quitting, e le nuove spettatrici non vogliono solo sogni da indossare, ma narrazioni in cui riconoscersi.
E allora ci chiediamo: questo film, così radicato in un’estetica e in una cultura del lavoro anni 2000, può ancora parlare anche a chi oggi guarda la moda con occhi nuovi e meno idealizzati?
La moda nel cinema: quando i vestiti parlano più della sceneggiatura
Diciamoci la verità: ricordiamo più il guardaroba di Miranda Priestly che la trama completa del film. Le frasi cult sì, certo (vale sempre la pena riguardare il monologo sul “ceruleo”), ma sono gli abiti ad aver scolpito l’immaginario: la cintura sottile su Andy che si trasforma, il cappotto gettato sulla scrivania, il completo viola di Emily. Ecco perché l’hype intorno al sequel non è (solo) narrativo, ma profondamente visivo: vogliamo vedere cosa indosseranno. Più che sapere cosa faranno.
In un’epoca in cui i contenuti si consumano in screenshot, reel e carrellate di “10 look da copiare subito”, la moda al cinema non è più solo costume. È linguaggio, è drammaturgia estetica. Lo sapeva bene Sex and the City, dove gli outfit di Carrie & Co. generavano dibattiti quanto le scelte amorose. E lo stesso succede oggi con Euphoria, Emily in Paris, Barbie o persino con Succession e il suo minimalismo da miliardari disfunzionali.
Il rischio, però, è quello di aspettarsi che i vestiti bastino a reggere un intero sequel. Ma cosa succede se la storia, oggi, non regge più lo stesso peso di 20 anni fa?
Da Andy a noi: generazioni a confronto
Quando uscì Il Diavolo veste Prada, molte di noi erano adolescenti, universitarie o appena entrate nel mondo del lavoro. Guardavamo Andy correre tra redazioni, bozzetti e cappotti Balenciaga con l’entusiasmo (e l’ingenuità) di chi credeva ancora che “fare gavetta” fosse un passaggio necessario, quasi nobile. La moda ci appariva come una torre d’avorio faticosa ma affascinante, e Miranda Priestly, pur spietata, era l’ideale inarrivabile da cui ottenere legittimazione.
Ora, per chi allora sognava le scrivanie in open space e oggi si ritrova tra contratti precari, videocall e LinkedIn burnout, quel mito scricchiola. E viene da chiedersi: avremmo ancora voglia di lottare per quel tipo di riconoscimento? O abbiamo imparato a dire “no grazie” anche a una borsa Saint Laurent?
Nel frattempo è arrivata una nuova generazione, la Gen Z, che Il Diavolo veste Prada lo scopre ora, in clip su TikTok e nei meme su Miranda. Lo vive come una reliquia estetica, non come un’educazione sentimentale al lavoro. Per loro, Andy non è una ragazza in crisi identitaria. È un filtro, un trend audio, un personaggio vintage.
E allora forse è qui il punto: Il Diavolo veste Prada 2 non deve parlare a chi siamo state, ma a chi siamo diventate. E se possibile, a chi oggi guarda alla moda non come un mondo da conquistare, ma come una struttura da decostruire.
Il lavoro da sogno è ancora quello che ci consuma?
Non serve aver messo piede in una redazione patinata per sapere che il mondo creativo, sotto certi lustrini, può essere stancante, competitivo e spesso ingestibile. Lo racconta bene Roberta Lippi nel suo libro The Magazine, un memoir schietto e ironico che smonta dall’interno l’idea romantica del “posto figo” in cui lavorare. E in fondo è lo stesso cortocircuito su cui si regge Il Diavolo veste Prada, che da sempre mette in scena una verità doppia: bellezza e tossicità, successo e sacrificio, glamour e burnout. Solo che allora non lo chiamavamo così. Era “farsi le ossa”, “restare finché non te ne vai tu”. Oggi, invece, lo chiamiamo con il suo nome: fatica cronica.
Oggi abbiamo un nome per tutto: overworking, hustle culture, burnout, e sappiamo che secondo un report del 2023 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 40% dei lavoratori under 35 in Europa presenta sintomi da stress cronico legati alla sfera professionale. E se negli anni 2000 Andy era pronta a mollare tutto per la carriera dei sogni, oggi siamo molto più inclini a mollare tutto per riprenderci un weekend senza notifiche.
Il punto è: quanto siamo cambiate? E quanto è cambiata la narrativa che ci dice che solo il sacrificio produce valore? Forse non vogliamo più essere Andy. Ma nemmeno Miranda. Forse vogliamo solo una moda che ispiri senza consumare, un lavoro che entusiasmi senza bruciare, e dei film che lo raccontino senza semplificare troppo.
Chi vestirà Miranda, Andy ed Emily nel sequel?
Diciamolo chiaramente: uno dei motivi per cui Il Diavolo veste Prada 2 ha fatto esplodere l’hype è la moda. Non tanto come concetto astratto, ma i look, i vestiti, gli outfit da sgranare frame dopo frame. In questi giorni sono comparse le prime foto dal set, street look newyorkesi, cappotti strutturati, spalle nette, e immediatamente è scattata la caccia allo stilista: chi vestirà le protagoniste oggi, vent’anni dopo?
Nel primo film il guardaroba era curato da Patricia Field (la stessa di Sex and the City), con un cast di brand che definì un’epoca: Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Donna Karan, Prada, ovviamente. Andy indossava una giacca Chanel con stivali a coscia, Emily alternava colli in pelliccia e tubini avvitati, e Miranda fluttuava tra cashmere bianchi, occhiali da sole neri e borse Birkin come se fossero sacchetti del pane.
Oggi la domanda è: ce le immaginiamo ancora così? Oppure qualcosa cambierà?
C’è chi ipotizza un ritorno di Field (che però ha dichiarato di non essere coinvolta), mentre circolano voci su Micaela Erlanger (stylist di Lupita Nyong’o) o Gabriella Karefa-Johnson per portare uno sguardo più aggiornato. I brand? Potrebbero essere The Row, Loewe, Balenciaga, Alaïa, JW Anderson — marchi capaci di unire eleganza estrema, ironia e potere visivo. E poi c’è l’ipotesi più intrigante: Emily diventata PR di sé stessa, vestita in Ferragamo da head-to-toe, e Andy? Forse non più “messa a posto”, ma consapevolmente imperfetta, tra trench oversize e sneakers cult.
Il punto è che oggi non basta un completo firmato per diventare iconica: servono identità, coerenza e narrazione visiva. E noi saremo lì a guardare, screenshot alla mano.